Per provare a “marcare stretto” il tema proposto, il rapporto tra coesione e sviluppo in rapporto agli “ultimi” e in riferimento alla nostra esperienza di inserimento socio-lavorativo dei detenuti, parto da alcune cifre relative alla nostra realtà imprenditoriale. Officina Giotto, il brand con cui ci presentiamo, appartiene al Consorzio sociale Giotto di Padova. Al consorzio aderiscono due cooperative sociali di tipo B: Giotto e Work Crossing, che impiegano complessivamente circa 450 lavoratori, di cui il 35% in condizione di svantaggio, per un fatturato complessivo di 20 milioni di euro nell’ultimo anno. Siamo operativi su molti fronti, raggruppati in sette ambiti principali: ristorazione, congressuale, servizi, gestione del verde, università, lavorazioni penitenziarie, pasticceria.
Il consorzio è noto soprattutto per le attività lavorative che coinvolgono i detenuti della casa di reclusione “Due Palazzi” di Padova. Questa però è solo una parte del nostro lavoro. Da una parte infatti operiamo anche con persone svantaggiate dal punto di vista fisico, psichico, psicofisico, per dipendenze e con fasce deboli, dall’altra le lavorazioni carcerarie concorrono solo in parte al fatturato complessivo delle cooperative consorziate.
Il nostro quindi è un lavoro che coinvolge molti “ultimi”, persone che normalmente vengono scartate o quanto meno tenute a margine dei processi produttivi. Nei giorni scorsi a questo proposito sono stati illuminanti per me alcuni pensieri di papa Francesco pubblicati in prima pagina del Corriere della Sera mercoledì 19 febbraio. Si tratta della prefazione all’ultimo libro del cardinale Gerhard Ludwig Müller, uscita sul giornale con il titolo «La ricchezza è un bene se aiuta gli altri». Papa Francesco ricorda che ci sono povertà anche non legate all’economia, che ci richiamano alla nostra originale, creaturale dipendenza, perché «in ogni epoca e tappa della vita ciascuno di noi non riuscirà mai a liberarsi totalmente dal bisogno e dall’aiuto altrui, non riuscirà mai a strappare da sé il limite dell’impotenza davanti a qualcuno o qualcosa». Di qui la necessità di «rimanere umili e praticare con coraggio la solidarietà, come una virtù indispensabile allo stesso vivere.
«In ogni caso», aggiunge Francesco, e questa è la frase che mi sembra centrale, «dipendiamo da qualcuno o da qualcosa. Possiamo vivere ciò come una debilitazione del vivere o come una possibilità, come una risorsa per fare i conti con un mondo in cui nessuno può far a meno dell’altro, in cui tutti siamo utili e preziosi per tutti, ciascuno a suo modo». Per questo «quando l’uomo si concepisce così e si educa a vivere così, l’originaria povertà creaturale non è più sentita come un handicap, bensì come una risorsa, nella quale ciò che arricchisce ciascuno, e liberamente viene donato, è un bene e un dono che ricade poi a vantaggio di tutti».
La citazione è lunga, ma devo dire che raramente ho sentito fotografata con tale esattezza un’intuizione che in noi è stata presente fin dagli inizi, certo non con questo grado di consapevolezza, rispetto a tutto il nostro lavoro, non solo all’inserimento delle persone svantaggiate. Noi siamo cioè abituati a concepire come assolutamente realistico il fatto che siamo autonomi e sappiamo gestirci da soli. Quindi il fatto di essere “ultimi”, o comunque di avere svantaggi che limitano le nostre potenzialità, è uno spiacevole incidente che non si sa bene come classificare, che va occultato. Invece le cose stanno esattamente al contrario. Occorre educarci alla nostra condizione originaria, ad essere dipendenti, e quindi ad avere bisogno degli altri, a non vergognarci delle nostre fragilità, ma a trafficarle, mettendole in gioco. Questo credo sia il risvolto operativo dell’umiltà a cui richiama Francesco. È un atteggiamento concretissimo che si evidenzia soprattutto sul lavoro. Chi non si concepisce come autonomo è più collaborativo, favorisce una circolazione migliore delle informazioni, crea coesione, consente alla comunità (all’azienda) di valorizzarlo e di sopperire nello stesso tempo alle aree in cui non è in grado di operare.
Quando parlo di valorizzazione, intendo due livelli:
1. la valorizzazione della persona. Nel lavoro in carcere appare evidentissimo che il vero valore aggiunto è la persona e che tutto dipende dalla capacità della sua libertà di (ri)mettersi in gioco. Faccio un esempio. Esiste un’occupazione più svalutata nel contesto sociale dell’operatore di call center? Normalmente, si pensa a questo tipo di lavoro come un’occupazione passeggera, in attesa di soluzioni migliori, con motivazioni e qualità del lavoro proporzionali alla scarsa considerazione. L’esperienza che invece abbiamo maturato nel carcere Due Palazzi ci mostra che quello dell’operatore di call center è uno dei posti di lavoro più ambiti. I nostri operatori, sia quelli che ricevono le prenotazioni delle visite specialistiche per le Usl, sia quelli che effettuano attività di telemarketing soprattutto nel settore delle forniture energetiche, ricevono una formazione di nove mesi e si sottopongono a un aggiornamento continuo. La loro attività è costantemente monitorata in un’ottica di controllo di qualità. La possibilità di comunicare, sia pure all’interno di severi protocolli, rappresenta un ponte con il mondo esterno che per chi come loro vive per anni dietro le mura di un carcere ha un valore aggiunto straordinario. Così assistiamo a tanti casi di persone che, in un contesto lavorativo altamente professionalizzante, riscoprono motivazione e sono in grado di fornire un servizio che ha un gradimento molto alto da parte degli utenti, sia per la professionalità, sia per l’umanità e la capacità di mettersi al servizio di chi sta dall’altro capo del filo.
2. la valorizzazione delle capacità residue. Lo sguardo all’interezza della persona, che possiede sempre risorse superiori a quelle che appaiono a prima vista, porta anche a una valorizzazione più oggettiva delle sue competenze e capacità residue. Faccio un esempio sul tema della disabilità e al settore del verde pubblico, per noi molto importante. A Chioggia, in provincia di Venezia, nel 2007 abbiamo inaugurato il progetto Acua, un centro di educazione ambientale dedicato al tema della biodiversità. In questo quadro ci è stato possibile impiegare persone con disabilità fisiche e soprattutto psichiche alternando lavoro di cantiere e lavoro in ambiente di serra, consentendoci di non sovraccaricare persone che hanno problemi di tenuta e non sopportano compiti troppo impegnativi per un lungo periodo. In alcuni lavori stagionali si dedicano alla coltivazioni dei fiori per le fioriture primaverili o autunnali, che poi verranno impiantati nei cantieri da parte del personale specializzato. Si tratta di un lavoro che non è il caso di far fare ad operai specializzati anche per i costi maggiori che ciò comporterebbe e che è funzionale all’economia e all’organizzazione complessiva dell’azienda.
L’aggettivo “residue” peraltro può essere anche eliminato: si potrebbe parlare esclusivamente di talenti delle persone. Penso alla presenza in carcere di detenuti cinesi o comunque provenienti dall’Estremo Oriente, dotati di una manualità e di una capacità straordinaria nei lavori che richiedono precisione e cura dei particolari. Una lavorazione in campo elettronico – l’assemblaggio di chiavi usb per la firma digitale – è stata avviata con successo grazie alla presenza di una persona detenuta capace di assicurare ai committenti grande accuratezza e velocità.
Va anche osservato che non esistono automatismi. Il lavoro è un fattore di crescita importante, ma se la persona non diviene cosciente del valore del suo lavoro, l’entusiasmo iniziale può lasciare il passo alla routine se non alla passività. Solo se recupera continuamente il senso del proprio lavoro, la persona non lo svuota di valore, non lo subisce ma lo vive in modo costruttivo, non lo manipola e sa stare al suo posto con entusiasmo, realismo e capacità di innovare. Non sempre e non tutti accettano un simile percorso, l’unico peraltro che compie e realizza, dà la soddisfazione di fare cose utili, fatte bene.
È stato giocoforza quindi fin dagli inizi della nostra avventura sociale e imprenditoriale in carcere, iniziata con un corso di formazione, investire – anche a costo di sacrifici – in un ufficio sociale, attualmente composto da due psicologhe del lavoro, per accogliere e accompagnare le persone, individuare le mansioni più adatte, collaborare con la direzione e gli operatori del carcere, anche se cerchiamo sempre di richiamarci tutti al fatto che l’attenzione alla persona non è il compito di un settore specifico, ma l’unico sguardo veramente oggettivo al lavoro proprio e altrui.
Tralascio altri fattori del nostro metodo, meno essenziali rispetto al tema proposto, anche se per noi fondamentali, come ad esempio la necessità di concepirsi non in modo autoreferenziale, ma all’interno di una logica di network. Il che ad esempio nel mondo del carcere significa dialogare con vari soggetti, dagli agenti di polizia penitenziaria, agli operatori esterni anche volontari, al personale del carcere, alla magistratura, fino al ministero e poi con l’imprenditoria locale e le pubbliche amministrazioni.
Come si è già in più punti accennato, nella nostra esperienza il principale mezzo di valorizzazione della persona è il lavoro. Oggi le lavorazioni di Officina Giotto coinvolgono circa 120 persone detenute, accanto agli operatori delle cooperative, mentre il numero complessivo di persone svantaggiate impiegate nel consorzio, carcerati compresi, è di 162. Le lavorazioni avviate riguardano pasticceria, cucina, gastronomia, call center, assemblaggio valige, montaggio biciclette, business key per la firma digitale, sfridatura di cartoncini per l’industria cosmetica o alimentare.
Perché il lavoro possa essere significativo per la persona occorre che sia un lavoro vero e utile. In due sensi. Da una parte per il lavoratore, dall’altra per il mercato. Il lavoratore deve avere una formazione specifica, una qualificazione, dev’essere accompagnato tenendo conto delle sue caratteristiche, deve avere mansioni ben definite, rispettare gli orari e rispondere del proprio operato ai responsabili di settore. Quanto al mercato, i prodotti e i servizi delle lavorazioni carcerarie devono qualificarsi per la loro qualità, non per l’etichetta di “sociali”. Dalle carceri italiane purtroppo escono ancora troppi “lavoretti” che forse si acquistano una volta per compassione o per fare del bene, non per effettiva utilità. È evidente che questi prodotti non dureranno sul mercato. Il sociale invece non può essere un alibi. Per questo diciamo sempre che i nostri panettoni devono essere venduti perché sono i più buoni, non perché sono sfornati in carcere, devono essere presenti alle manifestazioni di punta del settore, misurarsi con le pasticcerie di alto livello. Gli assemblaggi devono essere preferiti dagli imprenditori per gli scarti irrilevanti, per la celerità e la precisione, per la flessibilità. Il call center deve eccellere per competenza e capacità di rapporti umani degli operatori. L’imprenditore deve avere convenienza ad investire nel lavoro in carcere, la sua motivazione non può essere il buon cuore.
Se la persona è coinvolta in un lavoro vero, allora anche diviene realmente incidente in termini di coesione sociale. La cartina al tornasole per le lavorazioni carcerarie è soprattutto una: la recidiva. Chi lavora in carcere non torna quasi mai a delinquere. L’incidenza sulla recidiva dei percorsi di inserimento e rieducazione avviati dal Consorzio Giotto è inferiore al 2 per cento, a fronte di una media nazionale ufficiale che si aggira tra il 70 e il 90%. Evidenti i risvolti sociali di una simile dinamica, meno i risvolti economici, che però sono molto consistenti: ogni detenuto costa allo Stato circa 250 euro al giorno tra costi diretti e indiretti. Abbattere la recidiva dell’1% (cioè più o meno 600 detenuti) fa risparmiare circa 50 milioni di euro all’anno.
Sempre in tema di recidiva, nel 2012 abbiamo partecipato a un congresso internazionale a Buenos Aires, che per noi ha rappresentato lo spalancarsi di una finestra sul mondo. Ci ha aperto gli occhi sul fatto che il carcere è un’esperienza fallimentare in tutto il pianeta. Al di là delle intenzioni di chi vi opera, i penitenziari creano delinquenza, come dimostrano proprio le cifre sulla recidiva, altissime tanto in occidente come nei paesi in via di sviluppo. I rari esempi positivi, e anche questo ci pare significativo, avvengono quando si punta sulla libertà e la responsabilità del detenuto come soggetto di cambiamento e non solo destinatario di interventi. Attraverso il progetto europeo EUROsociAL ad esempio è iniziata una collaborazione con le Apac brasiliane, le Associazioni di Protezione e Assistenza ai Condannati, un metodo pionieristico e innovatore, in cui le carceri si caratterizzano per l’assenza di armi e di polizia. Parallelamente riscontriamo l’interesse di tanti altri paesi verso la nostra esperienza di lavoro in carcere. Contiamo nel giro di qualche mese di avviare una produzione di pasticceria anche nel carcere minorile di Chicago, grazie alla collaborazione delle autorità locali e di un imprenditore della ristorazione illuminato come Bruno Abate.
Detto questo, proprio il confronto con le altre esperienze internazionali mi fa dire che non credo si possa parlare di un “metodo Giotto”, esportabile o replicabile. Il nostro metodo definito sinteticamente sta nell’investire nella persona come risorsa e nel creare lavoro come strumento che consente alla persona di uscire allo scoperto, riguadagnare fiducia in se stessa e dare un contributo positivo. Proprio l’incontro con i brasiliani ci ha fatto capire che la nostra organizzazione non potrebbe essere replicata meccanicamente nel loro paese. C’è quindi un aspetto di libertà, anche di rischio se vogliamo, di applicazione del metodo in una valutazione via via diversa delle circostanze concrete, che costringe a non cristallizzarsi e, salvo pochissimi punti fermi, a ridefinire continuamente strumenti e modalità di lavoro. Qualsiasi approccio deterministico, non solo in carcere, è destinato a fallire.


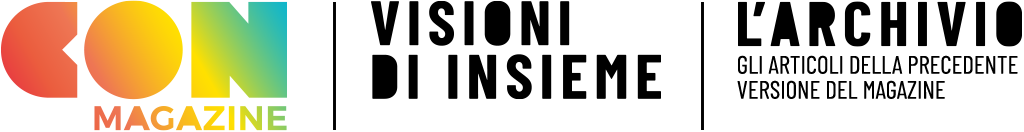




Nessun Commento