Nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1984, a quasi seimila chilometri da Taranto e a oltre dodicimila da Pittsburgh, una nuvola gonfia di isocianato di metile si sprigionò nel cielo di Bhopal, nella contea indiana di Mavda Pradesh, contaminando migliaia di persone. Ne morirono quattromila secondo le fonti governative, quindicimila secondo fonti non ufficiali, ma una stima assai verosimile e forse sottodimensionata ha calcolato in venticinquemila le vittime negli anni successivi e in 560mila le persone rese invalide da quell’incidente. Nonostante siano trascorsi trent’anni, gli effetti del più grande disastro industriale della storia non sono finiti. A Bhopal nascono bambini malformati, il tasso di malattie gravi – cancro, in primo luogo – sono più alti della media e la falda è inquinata. La multinazionale americana Union Carbide, nel cui stabilimento avvenne l’incidente, produceva in India il potente pesticida Sevin. Per risparmiare aveva disattivato i sistemi di sicurezza. Quando la sera del 2 dicembre un addetto alle manutenzioni incaricato di ripulire le tubazioni dell’impianto non isolò uno dei serbatoi zeppi di isocianato di metile, la sostanza, a contatto con l’acqua, raggiunse i 200 gradi centigradi. Quarantatré tonnellate di veleno evaporarono. Di notte la nube investì l’abitato. Non esisteva un piano di emergenza.
Infinitamente più gravi del disastro italiano di Seveso (1976), i fatti di Bhopal restano la pietra angolare per leggere le vicende attuali e riflettere trent’anni dopo su come si sia affrontato, a diverse latitudini, il rapporto tra industria e salute, tra produzione e ambiente.
A quasi seimila chilometri da Bhopal, la città di Taranto ha avuto insieme la fortuna e la sfortuna (fortuna in termini economici, sfortuna in termini ambientali) di vivere per oltre mezzo secolo a contatto con il più grande centro siderurgico europeo a ciclo integrale. Costruito dallo Stato italiano negli anni Sessanta su un modello industriale anni Cinquanta, l’ex Italsider (si chiama Ilva dal 1988 ed è stato privatizzato nel 1995) ha inoculato senza interruzione per mezzo secolo, giorno e notte, centinaia di sostanze velenose nel sottosuolo e nell’aria facendo di questa città della Puglia l’epitome della terra devastata dall’inquinamento, dove si muore per tumore il 12% più che nel resto della regione e la mortalità infantile è a quota + 21%, dove si emetteva il 90,3 % della diossina italiana, dove il bestiame non può pascolare senza contaminarsi e i bambini non possono giocare nei giardini pubblici perché sono contaminati anch’essi.
E’ un caso di cronaca di cui si parla da quando, tre anni fa (luglio 2012), un’inchiesta giudiziaria per disastro ambientale ha decapitato il gruppo industriale Riva portando alla luce connivenze tra politica, industria, giornalismo, affari.
Nei lontani giorni di Bhopal, il modello – Taranto era già nella sua fase declinante e Pittsburgh, la steel city americana in cui si produceva la metà dell’acciaio statunitense come a Taranto si producono i due terzi dell’acciaio italiano, aveva già disegnato la sua svolta puntando verso la ricerca, le tecnologie, la medicina. Grazie all’economia siderurgica Pittsburgh era passata dai 34mila abitanti degli anni Venti ai 700mila del periodo bellico, fino a discendere a 300mila con la crisi siderurgica anni Settanta, esattamente come Taranto aveva dilatato la sua popolazione dai 35mila abitanti di fine Ottocento ai 260mila dell’età dell’acciaio, conquistandosi il titolo di più ricca del Mezzogiorno con un reddito pro capite cresciuto dal 1951 al 1973 del 788,7%. Un miracolo nel miracolo del secondo dopoguerra.
Ora Pittsburgh, la città sporca e nera diventata celebre “per l’atmosfera fumosa e purulenta” – vecchia descrizione del professor Giorgio Nebbia – è la capitale tecnologica della Pennsylvania e una delle città americane in cui si vive meglio. Ha riconvertito la sua economia grazie a università, centri di ricerca, nanotecnologie, bioingegneria e a un polo sanitario da 50mila occupati. E’ il simbolo della scienza e dell’ambientalismo. Taranto, ridiscesa a 198mila abitanti e stritolata dalla doppia crisi siderurgica e ambientale, immagina di prolungare la sua parabola industriale cominciata nel 1960. Tre governi, con sette decreti legge (finora), si sono impegnati a salvare l’Italsider-Ilva. L’obiettivo è risanarla coprendo (probabilmente) i parchi minerali con una struttura lunga 700 metri, larga 264 e alta 80, ma lasciandola sostanzialmente com’è, estesa su 15 chilometri quadrati. Una città-industria nata su un modello anni Cinquanta. Servirà?
Trent’anni dopo è ancora utile rileggere “Mezzanotte e cinque a Bhopal”, libro in cui Dominque Lapierre e Javier Moro raccontavano il disastro indiano, il business, la povertà, le denunce inascoltate. Sembra passato. Non lo è. La Union Carbide ha pagato 470 milioni di dollari a titolo di risarcimento. La storia è finita così? No, la storia di Bhopal continua. Lo scheletro del vecchio stabilimento del disastro e il serbatoio E-610 da cui fuoriuscì la nube assassina attendono la bonifica; e continueranno, con conseguenze per niente rassicuranti, le storie di Seveso e di Taranto. Nessuno in buona fede è autorizzato ad associare altre vicende alla tragedia di Bhopal. Seimila chilometri, trent’anni, condizioni (e proporzioni) diverse ci separano dal disastro più grande della storia. Ma la globalizzazione dovrebbe servirci anche a questo: a guardare ogni giorno oltre la punta delle nostre scarpe.


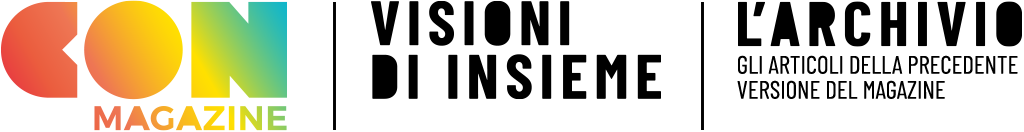




Nessun Commento