Cercherò di unire i puntini di queste figure – Dolci, Fonte, Olivetti, Milani e Basaglia – che pure sono tra di loro così diverse, estremizzando il concetto proposto dal titolo stesso di questo incontro (L’utopia della realtà, ndr), che ci offre già una sintesi. Lo farò dicendo quello in cui ho sempre creduto, cioè che l’unico strumento di trasformazione della realtà è l’utopia; che se non s’insegue qualcosa di grande, qualcosa che assomiglia ad un sogno, molto difficilmente le cose cambiano. E se quest’utopia non ha la forza di accendere la passione di milioni di uomini, l’utopia stessa rivela la sua dimensione negativa, e cioè una predicazione, l’indicazione di un sogno astratto. È solo quando l’utopia riesce ad entrare in relazione con il cervello e il cuore di milioni di esseri umani che le cose cambiano.
Prima di arrivare alle persone delle quali parlerò, posso fare degli altri esempi: il più evidente è quello di Martin Luther King, che parlò nell’agosto del 1963 a Washington e fece quello che probabilmente è uno dei più grandi discorsi politici della storia, qualcosa che assomiglia, almeno nella sua forma, più ad un gospel che a un discorso tradizionale. Evocò il sogno, la frase che tutti hanno nella testa, però se poi i neri hanno potuto frequentare le stesse università dei bianchi, sono potuti salire sugli stessi pullman dei bianchi, e un nero è diventato presidente degli Stati Uniti, certo dipende dalla forza del messaggio di Martin Luther King, ma dipende anche dal fatto che quando lui ha fatto questo discorso non era da solo. Se avesse parlato e fatto quel meraviglioso speech avendo davanti nessuno, il mondo non sarebbe cambiato. Lo ha cambiato Martin Luther King, ma lo hanno cambiato anche quei braccianti neri dell’Alabama che hanno attraversato l’America per andare a Washington e mettersi li.
Il mondo cambia quando un’utopia viene condivisa, e le persone delle quali noi qui oggi parliamo, sono tutte persone la cui utopia è stata condivisa; non erano sognatori individualisti, erano suscitatori di passione, d’impegno e di mobilitazione civile. Alcuni, è il caso di Renata Fonte, hanno pagato con la loro vita la scelta che hanno fatto: potrei citare Giancarlo Siani per esempio, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Libero Grassi e tanti altri nomi che purtroppo registriamo in questo paese, che è stato costretto ad avere tanti eroi. Si può unire però anche Adriano Olivetti, Danilo Dolci, Don Lorenzo Milani e Franco Basaglia, perché credo che rileggendo e intrecciando le loro biografie, il loro pensiero, possiamo unirle immaginando che siano l’espressione della parte migliore della storia del nostro paese. Nessuno di loro si può normalizzare, nessuno di loro ha una storia collocabile con facilità all’interno della tradizione del pensiero e anche dell’azione prevalente del nostro paese. Erano quattro irregolari e forse anche quattro minoritari; ognuno di loro occupa un posto particolare rispetto alle tradizioni cattoliche, liberale, socialista e comunista, ma è dentro al loro agire che io credo che noi possiamo ricercare alcuni dei concetti e persino delle ispirazioni, che possono motivare la vita di chi percepisce per sé un ruolo all’interno della società e quindi non decide di farsi realtà individuale astratta dal contesto nel quale vive.
Le tre parole che mi vengono in mente per unire queste figure sono: libertà, nel senso anche di liberazione, comunità, nel senso anche di coesione e comunità nel senso di attenzione per l’altro. So bene che i percorsi di queste quattro persone possono apparire lontani e forse loro stessi non si riconoscerebbero in questo accostamento, anche perché parlo di uomini di carattere forti, persino aspri qualche volta, di ribelli ma non di looser, di sconfitti. Per quanto in vita possano aver perduto battaglie e subito colpi, la loro eredità difficile è presente nel nostro sentire, almeno in quella della mia generazione, quella dei figli delle persone che sto citando, ma credo e spero anche in quello dei loro nipoti, persino se qualcuno non li ha neanche sentiti nominare.
Cominciamo dalla parola libertà: mi ha colpito, andando a rileggere le loro vicende biografiche, come tutti e quattro abbiano attraversato gli anni bui del fascismo. Il più vecchio di loro, Adriano Olivetti, nato nel 1901, aveva partecipato alla fuga di Turati, portandolo in macchina fino in Liguria da dove Sandro Pertini lo fece espatriare. Si era poi avvicinato al fascismo di sinistra cercando di introdurre in esso le sue idee per poi rimanerne scottato e finire esule inseguito dalle leggi razziali. Sul suo fascicolo c’era scritto ‘sovversivo’, e ‘sovversivo’ anche se era solo uno studente ventenne, era anche Franco Basaglia, quando venne preso dai fascisti a Padova perché legato con i sui compagni di corso all’anti – fascismo. Fu un’esperienza che lo segnò e che si portò dietro nel suo lavoro di psichiatra come un monito. Franco Basaglia nel suo arrivo in carcere molti anni dopo, lo paragona al suo primo arrivo in manicomio, due istituzioni totalizzanti e chiuse.
Ecco le sue parole:
“Quando entrai per la prima volta in una prigione, ero studente in medicina. Lottavo contro il fascismo e fui incarcerato. Mi ricordo della situazione allucinante che mi trovai a vivere. Era l’ora in cui venivano portati fuori i buglioli dalle varie celle. Vi era un odore terribile, un odore di morte. Mi ricordo di aver avuto la sensazione di essere in una sala di anatomia dove si dissezionano i cadaveri. Quattro o cinque anni dopo la laurea, divenni direttore di un manicomio e, quando entrai là per la prima volta, sentii quella medesima sensazione. Non vi era l’odore di merda, ma vi era un odore simbolico di merda. Mi trovai in una situazione analoga, una intenzione ferma di distruggere quella istituzione. Non era un problema personale, era la certezza che l’istituzione era completamente assurda, che serviva solamente allo psichiatra che lì lavorava per percepire lo stipendio alla fine del mese”.
Insomma il lunghissimo lavoro di Franco Basaglia per la chiusura dei manicomi, per la libertà e per la liberazione dei malati è certo frutto di un lungo lavoro di ricerca intellettuale, ma il punto di origine è in una esperienza personale incancellabile. Basaglia condivide con i matti la conoscenza di un’istituzione fatta per azzerare gli esseri umani, per cancellare dal contesto sociale la loro esistenza, per affermare un senso di claustrofobia e di morte che pervade la vita delle persone. Quel puzzo simbolico era il suo segnale di allarme.
Più volte nella mia vita sono andato a Barbiana, in forma pubblica talvolta, da solo e per riflettere più spesso. Mi è capitato di descrivere le stanze, la piccola stanza di quella scuola arroccata in pieno appennino come gigantesca. Starci dentro restituiva immediatamente quanto di enorme lì si è compiuto. Il senso dell’insegnamento di Don Milani, anche lui uomo complicato, scomodo, anche caratterialmente, non semplice, figlio di una famiglia d’importanti intellettuali, colto, raffinato, è proprio in una frase che rovescia questa percezione:
“Devo tutto quello che so ai giovani operai e contadini cui ho fatto scuola. Io ho insegnato loro soltanto ad esprimersi, mentre loro mi hanno insegnato a vivere. Io non ero così e perciò non potrò mai dimenticare quello che ho avuto da loro“.
Don Milani resta uno dei maggiori educatori del nostro paese, e qualcuno tra i quanti non lo amano, raccontano che era un maestro eccessivamente esigente, perfino aspramente esigente. Certo odiava la ricreazione, diceva che la ricreazione era per i borghesi e che i poveri dovevano e avevano il vantaggio solo a studiare. Eppure che cosa era il suo insegnamento se non la strada per riappropriarsi della libertà? I suoi ragazzi sapevano ma per essere liberi dovevano anche sapersi esprimere. Il muro su cui Don Milano aveva scritto “I care” rovesciava le scritte fasciste che nei primi anni ’60 ancora campeggiavano qua e là nei paesi: “Vincere e vinceremo”, “Credere, obbedire e combattere” è per me la più triste di tutte che purtroppo torna come una specie di inquietante richiamo, anche se depurata dalla sua dimensione ideologica, “Me ne frego”. Quella sua scuola piantata lì nel freddo del Mugello, era davvero una comunità di condivisione. È capitato di leggere qualche giorno fa un articolo di Roberto Saviano sull’Espresso, raccontava l’esperienza di una scuola romana molto particolare. Si chiama, e la conosco bene, Celio Azzurro, dal nome di un quartiere del centro della città. Un quartiere complesso e multi-etnico che si trova proprio alle spalle del Colosseo: “In quella scuola – dice Saviano – i maestri e gli alunni si dividono le merendine“. Si tratta di un asilo frequentato da piccoli immigrati e da italiani gestito assieme alla Caritas. Proprio negli stessi giorni sui giornali italiani si parlava del ruolo che stanno assumendo certe chat sui sociali di genitori, qui gli insegnanti vengono presi di mira, sbeffeggiati i ragazzi sempre difesi qualunque cosa abbiano fatto, la colpa è sempre degli altri, non delle famiglie che hanno troppo da fare, non dei ragazzi, perché altrimenti bisognerebbe porsi qualche domanda sul ruolo educativo dei genitori; e allora la colpa sarà sempre e comunque degli insegnanti. Che strano mondo il nostro, diviso a metà tra il Celio Azzurro e le chat libro nero. E mi è tornata in mente una poesia di Danilo Dolci, questo italiano così particolare, mezzo siciliano e mezzo goriziano, pacifista e non violento in un paese in cui a molti piaceva, e diciamoci la verità piace ancora molto, menar le mani. Anche Dolci era un educatore, aveva dedicato la scuola a questi versi:
“C’è chi insegna guidando gli altri come cavalli passo per passo: forse c’è chi si sente soddisfatto così guidato. C’è chi insegna lodando quanto trova di buono e divertendo: c’è pure chi si sente soddisfatto essendo incoraggiato. C’è pure chi educa, senza nascondere l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo ma cercando d’essere franco all’altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono: ciascuno cresce solo se sognato.“
Fate attenzione, non “ciascuno cresce solo sognando” che pure sarebbe stata una immagine molto bella ma solo se sognato dagli altri. Eccoli, gli altri. Quando prima parlavo di fraternità pensavo proprio a questo, all’idea, che in fondo è la realtà, di esistere soltanto nella relazione con gli altri. Lo specchio della tua vita non è la tua immagine riflessa ma è ciò che gli occhi degli altri vedono di te e ciò che tu pensi dell’immagine che loro riflettono. Solo in questo modo non aver paura degli altri, che siano i matti chiusi nei manicomi, i più poveri di tutti, quelli diversi per malattia o perché non c’è in fondo un solo modo di essere uomini e donne, oppure ancora i migranti quelli nei confronti dei quali proprio in questi giorni una professoressa ha invocato una sorta di soluzione finale.
Negli anni ’60 nel cuore degli appennini gli stranieri e i migranti non erano certo una realtà eppure Don Milani pensando forse ai grandi fenomeni migratori che attraversavano l’Italia da sud verso il nord, pronunciò una frase davvero esemplare, disse “Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri”. Patria, stranieri, comunità.
Adriano Olivetti, in apparenza dei quattro il più lontano. Un austero borghese, un industriale che è anche un intellettuale, sospeso a metà tra le sue radici ebraiche e quelle valdesi. Eppure è proprio lui a porre in Italia il tema della comunità, raccogliendo da filoni di pensiero lontani sia le strade più battute del liberalismo, del cattolicesimo, del solidarismo socialista, anche se ciascuna di queste tre grandi tradizioni ha dato per parte sua valore e forza all’idea di comunità. Olivetti è certo un pensatore ma il suo modo di affrontare le questioni non è quello della speculazione intellettuale. Sentite questa sua frase:
“La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica, giusto? Occorre superare le divisioni fra capitale e lavoro, industria e agricoltura, produzione e cultura. A volte, quando lavoro fino a tardi vedo le luci degli operai che fanno il doppio turno, degli impiegati, degli ingegneri, e mi viene voglia di andare a porgere un saluto pieno di riconoscenza.”
E a chi lo accusava, succede spesso, di essere un puro utopista replicava: “Spesso il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci sopra. E allora può diventare qualcosa di infinitamente più grande“. Nella nostra società di oggi, del frammento in cui tutto sembra stare insieme senza distanza, senza più privato, senza più distinzione, proprio ora la comunità appare più lontana e il sogno di Olivetti sembra sbiadire.
Olivetti e Don Milani non si sono mai conosciuti; morto in viaggio nel 1960 il primo, mentre già da qualche anno il secondo era stato mandato dalla Curia fiorentina nel suo esilio di Barbiana. Eppure una frase di Don Lorenzo potrebbe fare da epigrafe all’industriale Olivetti: “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è avarizia“. Politica contro avarizia. Certo siamo in tempi in cui la parola politica non gode di buona salute né di buona accoglienza, eppure per questi nostri padri come nella mia generazione, la frase di Milani come uomo di chiesa, appare illuminante nella pratica della nostra esperienza di vita insieme quasi ovvia.
Ma voglio tornare per chiudere a Franco Basaglia, perché ci troviamo nella sua casa e perché di tutti e quattro mi appare il più moderno e forse anche il più internazionale. Franco è riuscito a dare alla sua battaglia un segnale ampio che ha spaziato dal dibattito culturale alla costruzione di un immaginario condiviso, da un impegno professionale alla sua traduzione in atti politici concreti, in leggi, in innovazioni capaci di cambiare le condizioni di vita di decine di migliaia di persone rinchiuse e private del loro essere uomini e donne, e con questo di cambiare la vita anche di quelli che il manicomio lo vedevano magari passandoci davanti con l’autobus; a Roma ce n’è uno enorme che portava il nome involontariamente beffardo di Santa Maria della Pietà, e chi passava davanti a quelle istituzioni spaventose, finiva per credere che quei cancelli e quelle inferiate fossero una protezione inevitabile. Franco Basaglia ci ha obbligato a lasciare da parte ogni ignoranza, ogni diffidenza, ogni pigrizia a prendere atto del fatto che la ragione e la pazzia vanno comprese assieme. Lasciando il suo lavoro a Trieste, là dove portò a termine la prima esperienza italiana riuscita dal carcere manicomiale, ebbe a dire agli infermieri e ai medici che rimanevano, che “nel nostro mestiere la finalità è quella di affrontare, – trovare la maniera di affrontare la contraddizione che noi siamo: oppressori ed oppressi, e che dinanzi a noi abbiamo una persona che si vorrebbe opprimere. Bisogna fare in modo che questo non avvenga. L’uomo ha sempre questo impulso, di dominare l’altro; è naturale che sia così. È innaturale quando si istituzionalizza questo fenomeno oppressivo. Quando c’è un’organizzazione che, approfittando dei problemi contraddittori, crea un circuito di controllo per distruggere la contraddizione, assolutizzando i due poli della contraddizione ora in un modo ora nell’altro. Noi – diceva Franco – rifiutiamo questo discorso. Noi diciamo di affrontare la vita, perché la vita contiene salute e malattia“. C’è in queste parole una consapevolezza inquieta ed inquietante delle nostre contraddizioni, della complessità della nostra paura, della nostra natura. Però anche quell’aspirazione alla libertà di ciascuno, quell’essere all’interno di una comunità, quel voler essere fratelli, anche se una parte di noi spingerebbe al dominio, che è l’eredità più grande che abbiamo ricevuto da Franco Basaglia, da Adriano Olivetti, da Don Lorenzo Milani, da Danilo Dolci e da quanti, famosi o sconosciuti, hanno combattuto queste battaglie, ciascuno per la sua parte, chi facendo un grande discorso, chi ascoltando, chi facendo vivere nella pratica quotidiana l’idea che la realtà non sia solo quella che si fotografa con i propri occhi e con il proprio cervello, ma sia anche quella che si può immaginare e immaginandola cambiarla.
(Tratto dall’intervento tenuto il 22 ottobre 2016 a Venezia all’incontro “Un futuro mai visto – Franco Basaglia, l’utopia della realtà”)


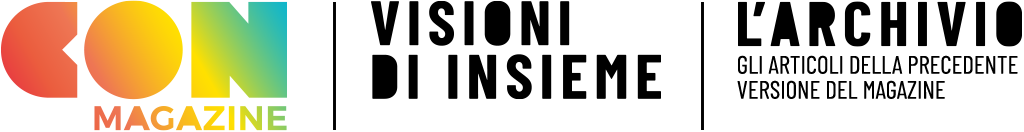




Nessun Commento