Che si materializzi in una startup o prenda tutt’altra forma, il futuro è un’impresa da inventare con creatività, spirito imprenditoriale e spinta all’innovazione. Tre doti che possono e devono essere allenate a scuola. Ne è convinto il salentino Daniele Manni, professore di informatica dell’Istituto Tecnico Galilei Costa di Lecce, che da anni forma giovani imprenditori, ma non solo.
Quando ha portato nelle aule il suo particolare metodo di insegnamento era considerato fuorilegge perché non si atteneva al protocollo. A distanza di anni, nel 2015, è stato tra i 50 finalisti al mondo del Global teacher prize, definito come il nobel dell’insegnamento. Lo scorso anno è stato tra i dodici finalisti agli Innovation and entrepreneurship teaching excellence awards, ossia il premio dedicato all’eccellenza didattica proprio in tema di innovazione e imprenditorialità. In entrambi i casi è stato l’unico italiano in gara. Oltre ai riconoscimenti internazionali, è diventato un esempio per molti docenti intenzionati a replicare la sua metodologia nelle proprie classi.
Qual è la peculiarità del tuo metodo di insegnamento?
La caratteristica principale è che da circa 20 anni spingo i miei alunni ad inventarsi una piccola impresa, una microattività imprenditoriale, sia questa un nuovo servizio, un nuovo prodotto, una nuova app. Insegno informatica, ma sono stato io stesso imprenditore fino al ’99. Ho creato quattro società (allora non si chiamavamo startup) e ad un certo punto ho deciso di lasciare l’attività imprenditoriale esterna e di portarla dentro la scuola e spingere i ragazzi verso questo percorso.
“Cosa ci inventiamo?” è la domanda che rivolgo il secondo giorno di scuola alle classi del primo anno. Dedico diverse ore di lezione al concetto di creatività spiegando come questa può essere alimentata; facciamo lezioni sull’innovazione riportando gli esempi concreti di giovani innovatori. Oggi infatti abbiamo tante esperienze pregresse dei miei studenti come testimonianze di ragazzi che si sono impegnati a inventarsi qualcosa.
Che riscontro hai dai tuoi studenti?
Da qualche anno la maggior parte dei ragazzi che si iscrive in questa scuola lo fa proprio per seguire il percorso formativo da me proposto. Talvolta all’inizio dell’anno sono loro stessi a proporre delle startup da creare. A volte si tratta di idee molto interessanti, altre un po’ sgangherate…
In effetti la mia idea iniziale era quella di “creare” quanti più imprenditori possibili. Poi mi sono accorto che non tutti hanno la stoffa o la voglia di essere imprenditori e quindi ho cominciato ad avere qualche perplessità su questo mio approccio, per poi ricredermi nuovamente. Molti ex alunni, infatti, mi hanno riferito che, al di là dello sbocco intrapreso dopo il liceo, il percorso formativo seguito a scuola ha rappresentato una vera palestra: li ha resi più consapevoli nel compiere scelte, più pronti nella risoluzione dei problemi e più resilienti, ovvero più capaci di adattarsi ai cambiamenti. Mi sono quindi reso conto che la tecnica didattica da me adottata è utile per tutti, a prescindere dal fatto che dopo si diventi imprenditori o meno. Questa per me è la soddisfazione più grande.
Qual è stata la reazione del mondo scolastico a questo tuo metodo di insegnamento?
Inizialmente fece un po’ scalpore. Vent’anni fa ero considerato un docente “fuori legge” perché non mi attenevo ai programmi ministeriali ma seguivo una mia strada. Adesso questo non è più considerato illegale perché dalla riforma Gelmini in poi ogni docente è libero di improntare il suo programma didattico come meglio crede.
In passato mi sono sentito ripetere da molti colleghi che stavo sbagliando, che ero fuorilegge, che se il ministero lo avesse saputo avrei passato i guai. Io però sono andato avanti. Con il riconoscimento internazionale tutto è cambiato e molti tra coloro che prima mi avevano boicottato si sono ricreduti. “Se una giuria di professionisti ha considerato questa attività da nobel allora dobbiamo riconoscerne la validità”, hanno pensato in molti.
Da fuori legge a candidato ad un premio Nobel. Vuoi parlarci dei riconoscimenti che hai ricevuto negli ultimi anni?
Tre anni fa, a mia insaputa, un alunno mi ha segnalato ad un premio internazionale di cui non ero a conoscenza, ovvero il premio nobel per l’insegnamento, il Global Teacher Prize. Il racconto che questo alunno fece di me li colpì talmente tanto che alla fine risultai tra i 50 finalisti. Da lì sono seguite una serie di segnalazioni e altri riconoscimenti. Gli ultimi tre anni dunque sono stati molto ricchi e intensi.
Come hai vissuto questo interesse nei tuoi confronti?
Da un lato quest’attenzione mi ha un po’ imbarazzato perché a me piace stare dietro le quinte e lasciar fare tutto agli alunni. Voglio che la fama ed il successo vadano a loro. Dunque mi ha un po’ infastidito che tutti i media avessero acceso i riflettori sulla mia persona. Poi però ho capito l’importanza del vostro lavoro perché tramite i giornalisti la mia esperienza è giunta alle orecchie di tantissimi docenti che da quel momento mi hanno contattato per capire come replicare questa esperienza nelle loro scuole, in Italia ma anche all’estero (in particolare in Olanda, Germania e Cina).
Partecipando a questi premi internazionali, infatti, mi sono reso conto che anche nelle altre nazioni l’imprenditorialità è poco presente nelle scuole superiori, ad eccezione di alcuni Paesi del nord Europa. Eppure a mio avviso si dovrebbe spingere molto di più in questa direzione.
Di recente ho avuto il piacere di conoscere un mio collega di Bergamo, Armando Persico, anche lui due anni dopo di me è stato selezionato tra i finalisti al premio nobel per lo stesso identico motivo: insegna l’imprenditorialità ai ragazzi under 18. Se due docenti in Italia insegnano imprenditorialità ed entrambi vengono candidati ad un Nobel, un motivo ci sarà! Le scuole, soprattutto quelle che insegnano economia, dovrebbero dedicare almeno un po’ di spazio a materie come creatività, innovazione e cambiamento.
Che startup hanno messo in piedi i tuoi studenti? Puoi farmi qualche esempio?
Mi è più facile raccontare prima di tutto quelle startup che sono ancora attive, perché in generale la percentuale è sempre piuttosto bassa. Io ero molto scoraggiato quando un giornalista mi chiese la percentuale di sopravvivenza: fino ad oggi ne abbiamo inventate una trentina e oggi sono attive 4. Lui mi ha fatto i complimenti perché generalmente la media è molto più bassa [1].
Tra le esperienze realizzate dagli studenti vi è un progetto sociale, il primo di questo genere: si chiama Mabasta e ha come finalità quella di prevenire e combattere dal basso bullismo e cyberbullismo. Questo progetto ha riscosso subito molto successo anche a livello mediatico.
Tra le altre startup create dai miei studenti vi è SmartSiti, creata dall’unione di due coppie di amici impegnati nella creazione di siti web. La bellezza di questa startup è che sta avendo successo e impiegherà altri giovani.
Dal momento che i minorenni non possono vendere ed emettere fatture, nel 2004 abbiamo creato insieme ad una mia collega e ad alcuni alunni di quinta superiore, quindi maggiorenni, una società cooperativa con la funzione di incubatore d’impresa.
Ci sono delle differenze tra il nord ed il sud? Pensi che al nord la tua esperienza sarebbe stata diversa?
Per quanto mi riguarda ho fatto qui quello che avrei fatto altrove. Forse il contesto geografico del nord lo rende un po’ più predisposto verso la libera impresa. Penso che la cultura del sud sia meno incline all’imprenditorialità e più proiettata verso il posto fisso. Checco Zalone la dice lunga su questo!
Pensi che il mito del posto fisso sia ancora vivo anche tra i giovani?
No, ormai no. E questo da una parte è il segnale di una disillusione dei ragazzi rassegnati all’idea di non trovare un’occupazione stabile. In molti sono disillusi perché bombardati da notizie negative sulla mancanza di lavoro, sull’aumento della disoccupazione e sull’emigrazione dei ragazzi all’estero.
Anche i tuoi studenti sono rassegnati?
Nella nostra scuola si respira un’aria diversa. I nostri ragazzi sono fiduciosi perché toccano con mano le esperienze dei ragazzi che hanno dato vita ad un progetto e per questo hanno ricevuto riconoscimento e guadagni.
Qual è la tua opinione della scuola italiana?
La scuola nel 90% dei casi purtroppo è identica a quella frequentata da me 40 anni fa. Del resto la maggior parte del corpo docente delle nostre scuole ha più di 50 anni ed è molto difficile convincere un professore di quell’età a cambiare metodo. Io non contesto i contenuti, che sono eccellenti. Ciò che critico sono le modalità di trasmissione di questi contenuti ed il modo di comunicare con i giovani che non tiene conto del contesto attuale. I ragazzi di oggi vivono in un mondo dinamico fatto di video, immagini, musica e parole che scorrono velocemente sui loro schermi e intorno a loro. Entrando a scuola tutto è diverso: ad esempio nelle classi italiane la comunicazione è quasi sempre unidirezionale.
Eppure con la nostra esperienza possiamo testimoniare che cambiando le modalità e rendendo partecipi i ragazzi delle scelte che si fanno si riscontra da parte loro un fervore diverso.
Secondo le stime i migliori talenti vanno via dall’Italia e in particolare dal Sud. Cosa ne pensi?
Il dato è sconfortante ed è triste pensare che le università italiane preparano in modo eccellente i giovani ma poi il nostro Paese non riesce a “sfruttare” questa preparazione. È come fare un grande investimento senza poter poi godere del risultato.
Cosa serve a tuo avviso per invertire questa tendenza?
L’unica soluzione per invertire questa tendenza è a mio avviso puntare sulla ricerca, creando centri di ricerca importanti, in tutta Italia ma soprattutto al Sud, dove i giovani possano sentirsi importanti e dedicare tutto il loro impegno per creare innovazione e far sì che questa innovazione abbia anche un successo commerciale.
In Italia viene data sempre un’accezione negativa al termine “commerciale”, invece non dovrebbe essere così: è importante che le cose siano vendibili e generino economia.
Se non si cambia la rotta i giovani continueranno ad andare all’estero per sentirsi appagati, almeno dal punto di vista lavorativo. In molti Paesi hanno capito che la ricerca è un investimento eccezionale, non mi spiego perché noi italiani non ce ne rendiamo conto.
Alessandra Profilio
[1] Daniele Manni ci ha spiegato che lestartup hanno un tasso di mortalità molto alta perché sono spesso carenti di un elemento. Ad esempio nel gruppo manca il comunicatore o al contrario c’è chi è bravo a comunicare ma è scarsa la qualità del prodotto in sé. La causa di mortalità di molte startup è insomma l’anello mancante. Per questo c’è una grande diffusione degli incubatori che forniscono quelle competenze o elementi mancanti ad un progetto per farlo decollare.


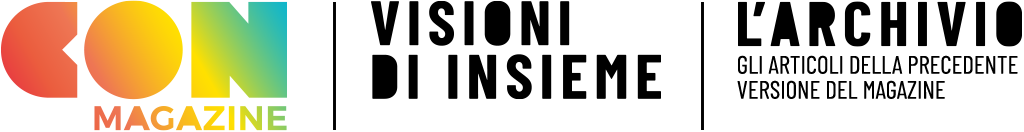




Nessun Commento