Sotto la coltre degli slogan urlati, della propaganda politica, dei pregiudizi e delle generalizzazione esiste il mondo variegato e complesso del lavoro degli immigrati in Italia. Un mondo silenzioso, che raramente finisce sui Tg perché non fa clamore, ma che costituisce un pezzo consistente dell’ossatura occupazionale e produttiva del nostro paese. Un mondo, soprattutto, con delle sue caratteristiche peculiari. Vi siete mai chiesti, ad esempio, perché le donne filippine facciano quasi sempre le colf? E gli uomini albanesi i muratori? O come mai gli immigrati nel nostro paese svolgano lavori meno qualificati rispetto ai loro titoli di studio? Per esplorare questo sottobosco di cui si parla poco e male ci siamo rivolti a Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia delle migrazioni all’Università di Milano, autore del recente saggio “Migrazioni” (Egea, 2017).
Come si struttura il lavoro degli immigrati in Italia oggi?
In Italia gli immigrati sono arrivati in modo sostanzialmente spontaneo, apparentemente senza essere stati richiesti. Ciò ha fatto sì che all’inizio, come oggi, siano stati percepiti come un problema sociale, quando in realtà il mercato del lavoro, famiglie e imprese, ha dimostrato di avere necessità di quel tipo di occupazione. Nel nostro paese, come in tutto il sud Europa, gli immigrati hanno mediamente un tasso di occupazione maggiore rispetto all’Europa del Nord, ma il loro inserimento lavorativo è schiacciato verso il basso: nove su dieci svolgono lavori manuali, il restante decimo è rappresentato soprattutto da lavoratori autonomi, quindi colletti bianchi solo sulla carta. I lavori degli immigrati possono essere definiti i lavori delle “cinque P”: pesanti, precari, pericolosi, poco pagati, penalizzati socialmente. Si è dunque verificata quella che chiamo integrazione subalterna: se da un lato la società italiana ha mostrato una certa disponibilità all’assunzione, all’assorbimento (si vedano le sette grandi sanatorie approvate in 25 anni), dall’altro ha inchiodato questa popolazione agli ultimi gradini della scala sociale.
Esistono in altri paesi politiche di integrazione nel mercato del lavoro più funzionali?
Nel Nord Europa l’immigrazione è più variegata: anche lì è arrivata largamente come immigrazione di manodopera, ma nel tempo, con l’insediamento stabile, fette importanti della popolazione immigrata hanno conquistato posizioni professionali più qualificate. Negli Stati Uniti, in Canada, in Australia ci sono persino politiche già da tempo volte ad attirare immigrazione qualificata, di lavoratori con alti livelli di istruzione e con specializzazioni, ad esempio medici.
Tornando in Italia, come si spiega il fenomeno dell’integrazione subalterna? È legato in maniera specifica al tema dell’immigrazione oppure più in generale ad una bassa mobilità sociale?
La struttura produttiva italiana in generale non si è molto evoluta verso una domanda di lavoro qualificato. Essere il secondo paese industriale d’Europa significa avere ancora tanti operai, avere industrie simili alle fabbriche, con pochi posti di quadro e un terziario avanzato poco sviluppato. Quindi ci sono problemi anche per i lavoratori italiani, tant’è che numeri sempre maggiori di giovani italiani istruiti vanno a cercare sbocchi all’estero per sfuggire alle tenaglie di una occupazione povera e precaria. Tuttavia ci sono delle specificità legate all’immigrazione, ad esempio il difficile (spesso mancato) riconoscimento dei titoli di studio ottenuti all’estero, oppure l’esclusione – fino a qualche anno fa ma sostanzialmente ancora oggi – dall’impiego pubblico, che in vari paesi è stato il principale motore di inserimento in posizioni di colletti bianchi per immigrati e figli di immigrati, essendo più egualitario delle imprese private.
Dal fenomeno dell’integrazione subalterna sembra potersi dedurre che non esiste una vera e propria competizione fra italiani e immigrati per l’accesso al mercato del lavoro, è corretto?
Bisogna precisare che in Italia abbiamo oggi 2,4 milioni di immigrati che lavorano regolarmente. Io non ricordo nessuno, me compreso, che 30 anni fa avesse previsto uno sviluppo del genere. Sui numeri, l’ingresso al lavoro degli immigrati è stato un successo straordinario in termini quantitativi. Tra l’altro la presenza e l’occupazione degli immigrati porta in alto il Pil e l’occupazione degli italiani. L’esempio più semplice è quello della donna adulta di classe media che trova un lavoro extra-domestico (in genere da colletto bianco) e a casa sua ha poi bisogno di qualcuno che prenda il suo posto per occuparsi dei figli, della casa, degli anziani genitori. Quindi il buon lavoro delle donne italiane trascina almeno un mezzo lavoro, di qualità modesta, per una donna immigrata. Inoltre l’occupazione degli immigrati è maggiore nelle province più ricche, dove c’è meno disoccupazione per gli italiani. C’è un’evidente correlazione positiva tra lavoro degli immigrati e lavoro degli italiani.
E invece come si spiega quella che lei chiama “specializzazione etnica”, ovvero il fatto che a determinate etnie corrispondano in maniera piuttosto puntuale certe occupazioni o attività commerciali?
Molto è dovuto all’attivismo delle reti etniche. I primi arrivati, per vari motivi, si sono inseriti in questi lavori umili. Poi una volta inseritisi in lavori che presentavano evidenti fabbisogni hanno sponsorizzato attivamente l’arrivo di parenti e vicini di casa connazionali. Questa è l’origine delle specializzazioni etniche. Su questi meccanismi di rete molto rigogliosi (almeno finché il mercato del lavoro è stato dinamico) si è poi inserita la produzione di stereotipi. Così il datore di lavoro ha iniziato a pensare, ad esempio, che le filippine sono brave domestiche, al punto che a Milano “filippina” è diventato sinonimo di “colf”. Così come gli albanesi, seppure partendo con una pessima immagine, si sono fatti una reputazione come muratori, le donne ucraine come assistenti familiari degli anziani, gli indiani Sikh come mungitori nella bassa Padana. Molto interessante è da questo punto di vista la tendenza dei datori di lavoro e più in generale della società italiana a collegare l’occupazione degli immigrati in queste posizioni sacrificate con delle caratteristiche culturali, come se realmente le filippine avessero la propensione a fare le domestiche, i Sikh i mungitori e così via. Stranamente non hanno mai la propensione a comandare, nemmeno nel caso dei Sikh che hanno grandi e antiche tradizioni guerriere: per noi hanno sempre l’attitudine a lavori di servizio! A volte arriviamo a giustificare queste convinzioni persino in termini religiosi, come ancora nel caso dei Sikh, che – si è soliti dire – lavorano bene nelle stalle perché hanno il culto della vacca sacra. Peccato che la religione dei Sikh non sia neppure l’induismo, per cui la vacca sacra non c’entra nulla!
Questo meccanismo di specializzazione etnica si è andato rafforzando nel tempo?
Già, è un meccanismo che si autoalimenta, infatti il nuovo immigrato che arriva nel nostro paese riesce a trovare più facilmente lavoro attraverso la propria rete di relazione con i connazionali piuttosto che attraverso la sua formazione professionale o il suo curriculum. Ma la rete dei connazionali lo inserisce negli ambiti che sono già appannaggio di quel gruppo etnico. Esistono anche, in alcuni casi, dei veri e propri mercati sommersi di posti di lavoro, in cui la rete preesistente vende una occupazione al nuovo arrivato: per esempio, tra le donne ucraine.
A fronte di questi dati e queste dinamiche che illustra, come spiega questa nuova ondata di xenofobia che sembra aver investito il nostro paese?
Va detto che come ci sono reti che favoriscono l’ingresso positivo nel mondo del lavoro, ce ne sono altre che favoriscono un inserimento negativo, come nello spaccio o nel mondo della prostituzione. Dall’altra parte c’è una tendenza nelle società riceventi, che è poi una tendenza della mente umana, a vedere lo straniero povero come un competitore o un nemico, o a volte come un povero da assistere. Noi semplicemente quando discutiamo di immigrazione riusciamo a non vedere quelle 800 mila colf e assistenti domiciliari che lavorano nelle famiglie italiane. Mentre pesa molto di più sul nostro immaginario il nigeriano omicida di Macerata. Il discorso si appunta sugli immigrati che fanno paura e c’è una fetta di opinione pubblica e alcuni imprenditori della paura che vanno a cercare appositamente i casi per poterci costruire sopra una narrativa. C’è sempre un nemico sottomano che può servire a costruire un discorso che ignora il contributo positivo che gli immigrati danno alla società. Quando poi si fa notare che gli immigrati lavorano la replica immediata è che rubano il lavoro agli italiani. Si trova sempre un modo di gettare la croce addosso agli immigrati, i quali peraltro non votando non possono neppure difendersi. In tempi di crisi gli immigrati, e soprattutto i richiedenti asilo, rivestono come in altre epoche il ruolo di capri espiatori.
Intervista di Andrea Degl’Innocenti


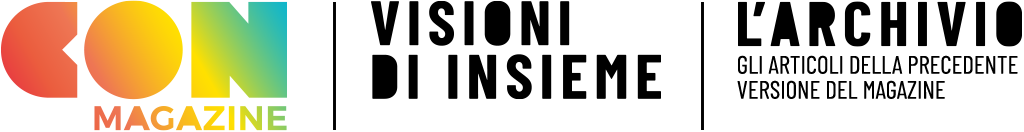




Nessun Commento